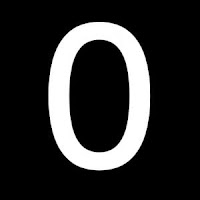Parigi, banalmente, mi manca. Come, con modi e toni diversi, mi mancano tutte le città in cui ho vissuto. Probabilmente è una cosa che ha a che fare col più generale senso di nostalgia per le cose del passato, che abbiamo tutti e sempre. Che a sua volta ha a che fare con l’ancora più generale desiderio di tornare a quando eravamo giovani, o almeno sfrontati, o almeno più giovani che adesso. Mi sono spostato spesso, nel corso degli anni, diciamo da un certo punto in poi. Così è finita che le città in cui ho vissuto per me rappresentano non solo, o non tanto, luoghi del mondo, quanto piuttosto fasi della vita. Marano è l’infanzia, Roma la prima giovinezza, il Galles la scoperta, Verona la maturità, Lisbona l’evasione e i capelli lunghi, Parigi i conti con se stessi. Monaco è stata zigzagare e raccogliere i cocci. Osnabrück è giocare alle costruzioni, ingegnandosi coi pezzi rimasti nella scatola. Il resto delle città, se ce ne saranno, sarà invecchiare.
In questi giorni sto cercando casa, che è un’altra cosa che, negli ultimi vent’anni, ho fatto periodicamente e regolarmente. Mentre salto da un sito all’altro, catalogo le ricerche, annoto e cancello opzioni, digito numeri e ripeto frasi a filastrocca, non posso fare a meno di tornare con la testa a tutte le volte del passato in cui mi sono ritrovato a compiere questi passaggi. E non posso fare a meno di realizzare quanto l’operazione sia diventata, col tempo, più faticosa, pesante, dolorosa. All’epoca di Lisbona, in quell’anno folle di Lisbona in cui ho scoperto amore vero e reflusso gastrico, cambiavo casa in media ogni due mesi, con una leggerezza e facilità che confinava in molti punti con l’incoscienza. Invecchiare non significa tanto cambiare, mi dico oggi: invecchiare significa modificare, giorno dopo giorno, la propria percezione del cambiamento. Il rapporto che si ha con la stabilità e le scosse, con le radici e con le rotte. Per quanto possa e sappia dirlo uno che non ha ancora imparato il proprio numero di telefono e il proprio CAP attuali, e gli mancano le radici ma tiene sempre un occhio alle rotte, e a quarant’anni ha un contratto di lavoro che gli scade tra due anni, scritto in una lingua che non è la sua.
Batignolles era il quartiere degli impressionisti. Al numero 11 del viale di Batignolles, che ormai si chiama Avenue de Clichy, c’era un caffè dove si riunivano Manet e Cezanne, Monet e Degas. Oggi quel caffè non c’è più ma sul muro è fissata una targa che lo ricorda. Me la fa notare Roseline, in una sera di vagabondaggio incastrata dentro le ultime due o tre intense settimane di vita parigina. Di giorno mi stresso tra burocrazia e scatoloni, la sera mi concedo di salutare luoghi e persone. Davvero non hai mai sentito parlare del Café Guerbois?, mi chiede. Davvero, rispondo senza sentirmi in colpa. Perché come fai a sentirti in colpa per non conoscere una delle centomila cose che stanno nascoste dentro Parigi? Mi viene da pensarlo sempre, in questi giorni che invece cerco casa in una pittoresca città qualsiasi del nord della Germania, mentre mi mostrano un appartamento e mi dicono, pensa te, che sto ad appena un quarto d’ora dal centro storico. Ci vai a piedi, mi dicono, al centro storico. Me li guardo, sorrido, faccio un’espressione superiore e: Io la sera passeggiavo per Batignolles, mi verrebbe da urlargli, con tono simile al tono di quell’attore che urla Io stavo col Libanese.
Che poi non è che abbia niente di speciale, Batignolles, a parte il nome che suona così bene e chissà da dove arriva. Forse è proprio il suo essere per niente turistico, e insieme parigino fin dentro ogni più piccola stradina, ad agganciarti: i bistrots così francesi e veri, le boutiques curatissime e il mercato coperto, i giardini inutilmente romantici. Roseline vive lì. Sono le mie ultime sere parigine e sto chiedendo alle persone che vedo, per salutarci, di portarmi nei loro quartieri, in luoghi sconosciuti ai più ma a loro familiari: un parco cittadino senza pretese, uno scorcio nascosto, il semplice café sotto casa. È un tour che ha preso il nome di pas d’adieu, e l’espressione è l’ultimo regalo che questa lingua, che ho amato tanto senza mai imparare a fondo, mi ha fatto. Io volevo banalmente rendere l’espressione passo d’addio, che però evidentemente non si usa o non si traduce così. Non, mais c’est très cool, mi dice Roseline. Perché se dici pas d’adieu quello che arriva è che in realtà non c’è nessun addio. Pas funziona come negazione: te ne vai, e Dio sa dove, a Monaco, in Baviera, nella terra dei crucchi, a zigzagare e raccogliere i tuoi cocci… ma pas d’adieu, non è mica un addio.
 |
| Édouard Manet: Al Café Guerbois |
L’ultima casa che ho visto potrebbe anche andare. È un attico, coi soffitti a spiovente che rubano qua e là centimetri in altezza. La posizione è buona: centrale e comoda abbastanza per il lavoro. L’edificio vecchio e arredato solo in parte: ci sarebbe da riempirlo un po’. Il vero punto debole è il bagno: sanitari malridotti e vasca senza doccia, per quella mancanza di centimetri in altezza che si diceva. Non mi ha fatto un grande effetto, a entrarci dentro, ma chi sa di case vecchie e prime impressioni converrà che spesso bastano una bella pulita e piazzarci dentro un po’ di oggetti propri per iniziare a sentire le quattro mura più familiari. Ho ringraziato il vecchio inquilino, un tipo simpatico che continuava a chiamarmi señor e ogni tanto usava parole spagnole pensando fossero italiane, gli ho detto che ci avrei pensato su e che l’avrei richiamato presto. Prima di tornare a casa, ho fatto due passi rapidi nei dintorni; lo faccio sempre quando vado a vedere appartamenti: mi convinco di abitare già lì, con tecnica vagamente attoriale, e provo a immaginarmici dentro. Mi sono perso tra le stradine pedonali del centro, pulitissime e quasi deserte, e ho fantasticato su come saranno e saremo tra qualche tempo, coi locali aperti, la gente fuori, la birra e le sigarette, la voglia di conoscerci e lasciarci di prima dei lockdown.
Io la sera passeggiavo per Batignolles, penso mentre metto una firma digitale su un contratto di locazione in pdf. Che poi non ci passeggiavo neanche così spesso, in realtà, giusto in quel periodo che vedevo Roseline, perché di mio abitavo da tutt’altra parte. L’ultima sera mi porta in un bar che si presenta semplice: con vini buoni e prezzi da banlieu, dice. Ha scelto un tavolo d’angolo: ci sediamo e mi chiede se ho già trovato casa, parlando di quella che, a contare e ricordare, è ormai quasi tre case fa. Se è vero che le città sono fasi della vita, allora forse mi manca Parigi anche perché della fase parigina mi manca, banalmente, incontrare qualcuno la sera in un bar in cui non ero mai stato. Le rispondo che sì, almeno all’inizio starò in una residenza che mi offre l’università, poi, con calma e sul posto, cercherò e si vedrà. Ordiniamo due bicchieri di rosso e le do il regalo che le ho portato, un libro di commedie di Molière in versione bilingue, perché a lei piacciono il teatro e l’italiano, e a me piace regalare libri. Dice che è bellissimo e che non se l’aspettava. Penso sia sincera, almeno per la seconda cosa. Scherziamo che non sono poi così avaro come mi pensava lei, mentre il cameriere torna coi bicchieri, e lei conclude che in effetti sono più malato immaginario, facendo riferimento a un episodio che adesso non sto a raccontare ma da cui non esco benissimo. Con Roseline non ci sentiremo per più di un anno, salvo poi riprendere a messaggiarci, sporadicamente, proprio ai tempi del primo lockdown, per raccontarci le lunghe giornate in case troppo piccole, le solidarietà tra vicini, i capelli tagliati corti, le differenze d’approccio tra nazione e nazione, prima marcate e poi via via più impercettibili.